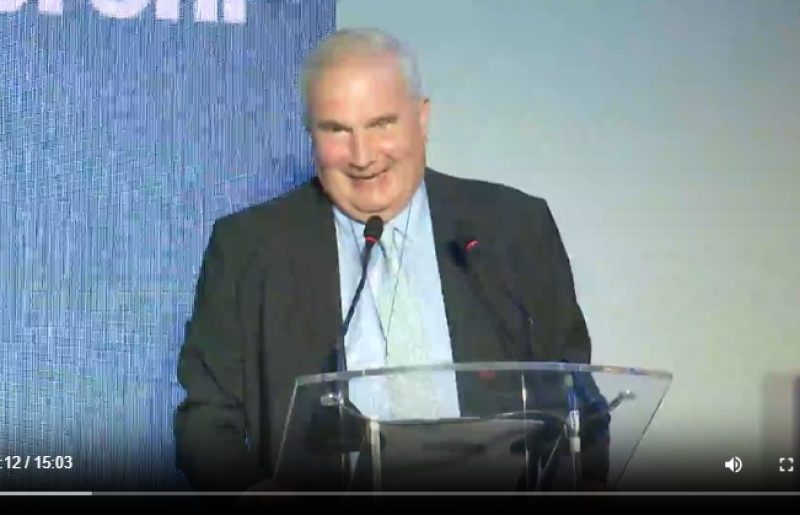Washington, 2 aprile 1968: dopo tre mesi di isolamento totale nella sua casa-laboratorio di Abbots Mead, in aperta campagna non lontano da Londra, Stanley Kubrick presenta al pubblico e alla critica il suo lavoro più ambizioso, “2001: Odissea nello spazio” dal soggetto del guru della fantascienza Arthur C. Clarke.
Un progetto rivoluzionario e un film che entra di prepotenza nella storia del cinema: oggi si può anche leggerlo come un’icona di quell’utopia esistenziale che innerva la stagione dei grandi cambiamenti e dei fermenti che, dall’America all’Europa, segnano il fatidico anno 1968.
Le passioni, le sensibilità e le utopie del sessantotto si mescolano in una pellicola che ha stregato il mondo. Con un salto temporale che ancora oggi lascia senza fiato, l’inizio di “2001: Odissea nello spazio” trasporta l’uomo dall’alba della preistoria al futuro. Un romanzo di celluloide che stravolge le certezze, tanto da riscrivere storia e storie di cultura classica e popolare.
Sequenze interminabili esaltate da una scelta musicale dirompente: l’opera 30 del compositore tedesco Richard Strauss. Fino ad allora legata ad un solo nome: Così parlò Zarathustra. Una composizione ispirata ad un’altra grande opera di fine ottocento, all’omonimo componimento poetico-filosofico del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche.
Un paradossale intreccio di destini artistici che nel corso di due secoli si sovrappongono al punto che il primo prende il nome del secondo generando una straordinaria simbiosi immaginaria.
E’ probabilmente capitato a tutti di leggere in un programma musicale l’esecuzione di “Odissea nello Spazio”. Senza troppe retoriche bastava il nome del film per far comprendere a tutti quale fosse l’opera di Strauss. Ed è forse nei 50 anni della prima proiezione di “2001: Odissea nello spazio” che si celebra un anniversario non scritto ma unico, romantico ed emozionate.
L’intreccio tra musica e immagini. Quella leggera insolenza che davanti ad uno schermo rapisce l’attenzione e fa irruzione nei sentimenti annientando, talvolta, la razionale riservatezza dell’essere. E’ in quell’istante che Strauss diventa Kubrick, che l’immagine diventa musica e che la musica diventa immagine.
Non è confusione ma è emozione che riesce ad esaltare l’arte. Così è stato ed è per la Cavalcata delle Valchirie del compositore tedesco Richard Wagner, epica colonna sonora di Apocalypse Now e di almeno almeno altre 10 pellicole.
Come l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni che chiude la scena di dolore de Il Padrino atto Terzo. La toccante scena del film Philadelphia: nel video, Andrew Beckett (interpretato da Tom Hanks) ascolta Maria Callas eseguire un’Aria tratta dall’Opera Andrea Chénier di Umberto Giordano traducendone lentamente i versi.
La bellissima e drammatica Ballata in Sol minore, Op. 23 di Chopin suonata dal pianista polacco, di origine ebrea, Władysław Szpilman scoperto dall’ufficiale tedesco in una soffitta per sfuggire alla furia nazista, nel fil Il Pianista di Roman Polański.
Solo pochi appunti, accenni di una storia interminabile.