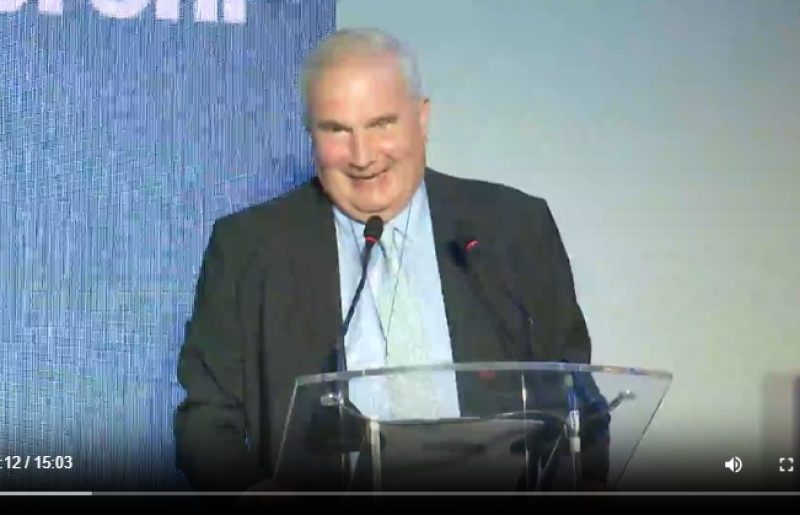Se, in un caldissimo ed afoso pomeriggio di luglio, più di trecento persone si ritrovano nel chiuso di un auditorium è perché l’argomento di cui si parla, oltre che di attualità a dispetto del tempo trascorso, è di interesse vastissimo. Tanto più se il tema oggetto di dibattito è di carattere politico e come tale non proprio popolarissimo.
Se, in un caldissimo ed afoso pomeriggio di luglio, più di trecento persone si ritrovano nel chiuso di un auditorium è perché l’argomento di cui si parla, oltre che di attualità a dispetto del tempo trascorso, è di interesse vastissimo. Tanto più se il tema oggetto di dibattito è di carattere politico e come tale non proprio popolarissimo.
Epperò è quanto accaduto ieri pomeriggio nell’aula Mendel al complesso della Trinità, dove Giuseppe Fioroni, presidente della commissione Moro, ha presentato il suo libro, scritto a quattro mani con la giornalista Maria Antonietta Calabrò, dal titolo “Moro: il caso non è chiuso. La verità non detta”. Circa trecento pagine incentrate sulle risultanze dei lavori dell’organismo d’inchiesta interparlamentare negli ultimi 4 anni, dove non mancano considerazioni e argomentazioni di carattere socio-politico di respiro più ampio.
A moderare la tavola rotonda Lucio D’Ubaldo, mentre il ruolo di relatore d’accezione è spettato all’ex ministro Graziano Delrio, uno che, come Fioroni, militando in quel lontano 1978 nella Democrazia cristiana, i tragici fatti del rapimento e dell’uccisione del grande statista li ha vissuti emotivamente da vicino, oltre che da spettatore come milioni di italiani.
Il punto centrale di tutti i ragionamenti, al di là della verità fattuale attorno alla quale lavorano da decenni magistrati, storici e giornalisti – come emerso dagli interventi di Delrio e Fioroni – è uno soltanto: l’attualità della lezione di Aldo Moro nel riaffermare i principi della democrazia in Italia sanciti dalla Costituzione. Egli aveva capito, già negli anni Settanta, che si stava incrinando il rapporto tra eletti ed elettori, da qui la necessità di allargare il più possibile la base della partecipazione alla vita politica (che a livello generale si espresse nella teorizzazione prima e nell’attuazione poi del compromesso storico). E pensare – ha notato Fioroni – che Moro faceva tutto questo quando a votare ci andava oltre il novanta per cento della popolazione. Eppure, nonostante ciò, aveva intuito che qualcosa stava per cambiare, figuriamoci che avrebbe potuto dire se fosse stato testimone di questi anni in cui la classe politica, se va bene, è legittimata da affluenze che non arrivano neanche al 50 per cento. Questa a ben vedere è la fine della politica, anche perché è essa stessa, sempre più debole, ad auspicare basse partecipazioni all’esercizio democratico laddove, non potendo contare nessuno su masse di elettori alle spalle, ci si affida a percentuali dello 0 virgola pur di arrivare a gestire il potere.
Si dice – ha rimarcato Fioroni – che la Prima Repubblica non è morta agli inizi degli anni Novanta, ma proprio in quella primavera di 40 anni fa quando le Brigate Rosse misero il silenziatore ad una delle menti più lucide del ventesimo secolo. Perché ciò sia avvenuto è ancora da scoprirlo del tutto, posto che – arguta considerazione di Delrio – le verità finora emerse sono state sempre in qualche modo funzionali al contesto storico in cui sono state espresse. Il che non vuol dire che non contengano elementi preziosi per un’analisi il più possibile oggettiva dell’evento, il punto è che non è facile riannodare il filo che le collega tutte insieme.
Moro – che dall’interno delle istituzioni aveva potuto osservare in prima persona i meccanismi che ostacolavano una piena maturazione della democrazia italiana, a favore dei quali sembrano aver giocato un ruolo decisivo i servizi di più Paesi e altri organismi più o meno occulti – sapeva che la nazione, per determinare la propria libertà, aveva bisogno di tutte le proprie componenti sociali e d’altra parte, il dividi et impera, che ricorre sovente nella storia di ogni epoca, è l’arma migliore per chi, magari dall’esterno, voglia affermare la propria egemonia su un popolo. E’ questo il movente del suo impegno e, paradossalmente, ma neanche tanto, dei suoi assassini.
Le verità emerse dalla nuova Commissione d’inchiesta Moro 2 – si legge nel frontespizio del volume – sono sconcertanti. Quattro anni di lavoro, migliaia di documenti desecretati dagli archivi dei servizi segreti italiani, centinaia di nuove testimonianze, nuove prove della Polizia scientifica e dei Ris dei carabinieri hanno rivelato molti nuovi, sorprendenti elementi.
Qualche esempio. Moro guardò negli occhi chi gli sparava, non morì sul colpo, ma in modo atroce, dopo una lenta agonia. Il suo carceriere trovò rifugio da latitante in una palazzina dello Ior, la banca vaticana. L’omicidio ben difficilmente è potuto avvenire nel box di via Montalcini 8, così com’era nel 1978. Almeno 2 terroristi della Rote Armee Fraktion potevano essere in via Fani. Fu un imprenditore israeliano che fornì i 10 miliardi del riscatto consegnati a Paolo VI. Le fazioni palestinesi giocarono un pesante ruolo nella trattativa. Durante il sequestro passarono alle Br documenti top secret della Nato. Infine emerge uno scenario internazionale del delitto che i brigatisti hanno sempre negato.
Purtroppo anche in molte rievocazioni in occasione dei quarant’anni del rapimento è stata riproposta la vecchia narrativa, messa a punto come un abito su misura.