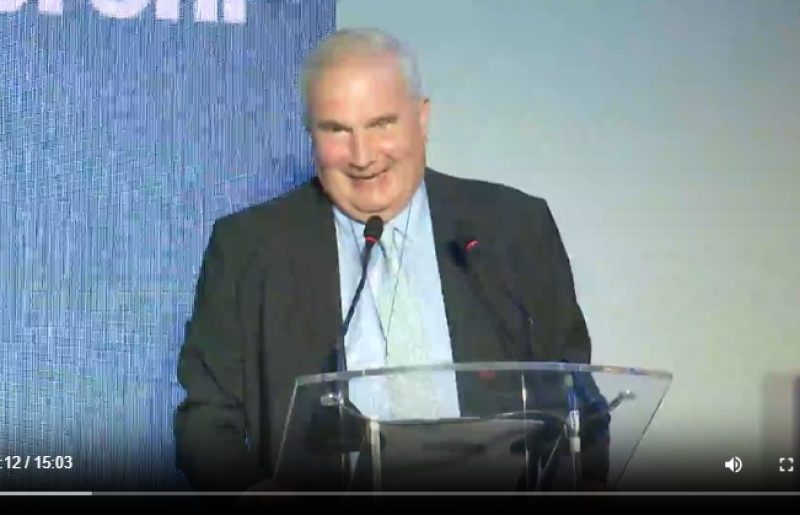di Angelo Allegrini (*)
Ho incontrato Aldo Moro una sola volta, nonostante nella Democrazia Cristiana delle correnti ero stato affiliato, quasi per caso, alla compagine dei “morotei” guidata in provincia di Viterbo dal giovane e capace sindaco di Vitorchiano, Renzo D’Orazi, purtroppo prematuramente scomparso.
Era il 1977, il 13 maggio per la precisione, a Bergamo, nella circostanza del XV congresso nazionale del Movimento Giovanile D.C., poco meno di un anno prima del suo vile assassinio.
C’era un clima molto teso; la parte alta della città – ove doveva svolgersi il congresso – era stata occupata da gruppi di estremisti di sinistra che avevano posto barricate e cavalli di frisia agli accessi, con i tassisti che per paura si rifiutavano di accompagnare i delegati; sempre a Bergamo, la notte precedente erano stati assaltati e bruciati gli stand della Festa dell’Amicizia mentre il giorno prima, a Roma, una studentessa di diciotto anni, Giorgiana Masi, era rimasta uccisa, a Ponte Garibaldi, in un episodio riconducibile alla strategia della tensione rimasto oscuro, durante una manifestazione indetta dal Partito Radicale in cui si erano infiltrati diversi facinorosi provenienti da Autonomia Operaia.
In quel contesto, Aldo Moro, presidente del Consiglio Nazionale della D.C., venne a concludere la prima giornata dei lavori e a ridare cuori a noi delegati o ad almeno quelli come me che erano rimasti intimoriti.
Dopo aver premesso che la vitalità del partito “si misura soprattutto sulla sua capacità di parlare ai giovani, di persuaderli, di impegnarli a sostenere […] la sua visione del mondo ed il suo progetto di convivenza civile“, Aldo Moro entrò nello specifico di quella delicatissima fase politica e, col suo linguaggio tutt’altro che facile da seguire, partendo dalle “difficoltà gravi che emergono dalle cose, che solo con una assurda ignoranza della realtà potrebbero immaginarsi per incanto rimosse, argomentò che In Italia ci siamo noi con le nostre possibilità e responsabilità. E ci sono gli altri, ai quali dobbiamo guardare, pur salvaguardando gelosamente la nostra diversità e dignità, con rispetto“.
A rileggere oggi le sue parole sembra quasi che stesse parlando del presente consegnato agli italiani dal risultato elettorale del 4 marzo:
Venendo al dunque della sua visione del futuro resa irrealizzabile dalla furia delle B.R., proseguì, “Nuove forze politiche sono ora in gioco e pongono gravi problemi; incomprensione, lontananza ed impaccio caratterizzano i rapporti con partiti nostri tradizionali alleati. Avviare, nelle forme rese possibili e richieste dalla situazione, un qualche collegamento è un lavoro lento e irto di ostacoli. Evidentemente si devono sciogliere con pazienza e senso di responsabilità, e nella misura del possibile questi nodi, avendo presenti da un lato la nostra tradizione e il compito che ci è stato affidato dall’elettorato con un atto di fiducia cui non possiamo venir meno, dall’altro la fretta del momento e le necessità, alle quali non possiamo essere insensibili“.
Parlò ancora, a braccio, improvvisando, perché di quello che disse poi non ho potuto trovare traccia nelle mie ricerche sui suoi appunti conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato e neppure nei resoconti dei quotidiani dell’epoca o del Popolo, il quotidiano ufficiale della Democrazia Cristiana; parlò, per mettere in guardia dai pericoli, dalle “talpe” che lavorano nel sottosuolo per distruggere il lavoro che viene svolto alla luce del sole rimanendo, in questo passaggio, ancora più oscuro almeno per lo stato di conoscenze che avevano gli italiani alla metà degli anni ’70.
I mesi che seguirono furono di una difficoltà senza pari ma anche pieni di speranze che rimasero incompiute.
A novembre di quello stesso anno, dopo aver già affermato in primavera il valore dell’Alleanza Atlantica e l’importanza dello scudo NATO, Enrico Berlinguer, a Mosca, sfidò il Cremlino sostenendo apertamente i valori della democrazia occidentale rappresentati dalle libertà personali e collettive, civili e religiose, nonché dal pluralismo politico, sociale e culturale.
Moro ricambiò il riconoscimento a gennaio del 1978 in un articolo mai pubblicato per Il Giorno dove rivendicava “libertà di manovra politica” sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica, riprendendo i concetti espressi al congresso dei Giovani DC: “A noi tocca decidere sulla base della nostra conoscenza, in piena autonomia, ma con grande equilibrio e senso di responsabilità“.
L’allarme sulle talpe lanciato a Bergamo rimase però, purtroppo, inascoltato, nonostante gli avvertimenti e gli altri segnali che, come ha accertato la Commissione di inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni e su cui tornerò prossimamente, avrebbero potuto non solo salvare la vita di Aldo Moro ma anche cambiare il destino del nostro Paese.
Solo pochi mesi dopo il suo omicidio venne a Viterbo l’on. Benedetto, consigliere regionale del Lazio e figlioccio politico di Moro che, in un convegno di corrente tenutosi al convento dei frati al Pallone, lanciò pesanti accuse al partito e alle forse di polizia; a me sembrarono così gravi e inconcepibili che decisi di abbandonare il gruppo dei morotei, tutto pensando fuorché in futuro mi sarei trovato professionalmente a studiare e ricercare fonti e documenti a conferma di quelle accuse.
Ma aveva ragione Raniero Benedetto.
(*) direttore Archivio di Stato di Grosseto, consulente Commissione di inchiesta sull’omicidio di Aldo Moro
[1- continua]